|
Il lavoro si pone come obiettivo quello di studiare i principi e le
pratiche innovative, necessarie ad una
gestione efficace del rischio territoriale
rispetto alle esigenze delle persone e del
territorio. La vicinanza alle zone colpite
dagli eventi alluvionali del 5 maggio 1998,
ha garantito la possibilità di conoscere in
modo dettagliato tutti gli strumenti e le
scelte messe in atto per una situazione
straordinaria d’emergenza, come quella di
Sarno. Infatti, il primo passo è stato
quello di studiare e di catalogare tutti gli
interventi (sia di tipo urbanistico, che di
tipo strutturale) realizzati sul territorio
dell’agro nocerino sarnese e del
Vallo di Lauro nell’intervallo tra il
dicembre 1999 e il gennaio 2001.
Quest’esperienza, fatta direttamente sul
territorio, ha permesso di individuare
quelle che erano le problematiche da
approfondire giacché, per il territorio in
esame, non erano state tenute in
considerazione. Si fa qui, in particolare,
riferimento all’ingegneria
naturalistica e alla pianificazione
partecipata. Queste due tipologie
d’intervento, infatti, nel territorio di
cui sopra, non sono state utilizzate ma si
è preferito realizzare un’estesa
cementificazione delle montagne e la
realizzazione d’interventi a volte lontani
dalle reali esigenze degli abitanti del
posto.
Le opere più importanti attuate in quest’area sono state realizzate
nei Comuni di Quindici e di Sarno.
L’intervento è stato diviso in due fasi,
una relativa alla messa in sicurezza del
territorio, ed una relativa alla
ricostruzione degli edifici danneggiati.
Relativamente alla messa in sicurezza sono
state realizzate opere di canalizzazione con
briglie e vasche finali di raccolta. Le
briglie tendono a stabilizzare il fondo
dell’alveo, a ridurre il rischio
d’erosione delle sponde, a diminuire le
pendenze e a contenere la velocità delle
correnti. I canali tendono a contenere,
senza esondazioni, le massime portate
previste; hanno larghezza di quattro o
cinque metri, tale da consentire agevolmente
le operazioni di pulizia con mezzi
meccanici. Le vasche terminali raccolgono le
acque e il fango convogliati dai canali,
esercitando un effetto di forte contenimento
delle portate uscenti, rallentando in modo
decisivo la velocità dei flussi,
consentendo così il deposito della maggior
parte del materiale solido trasportato,
agendo inoltre come un valido presidio per
le zone sottostanti e come contributo per
l’alleggerimento delle portate scaricanti
a valle. Le più imponenti opere per la
difesa dalle colate sono state realizzate
nel Comune di Quindici e consistono in due
vasche per l’accumulo di fango. La prima,
realizzata a valle del vallone San
Francesco, con un volume pari a circa 35.000
mc, presenta un manufatto attraverso il
quale il flusso è convogliato direttamente
verso il canale di recapito, mentre le
eventuali portate di fango di maggiore entità
sono inviate verso un canale a sezione molto
variabile che ne integra il percorso verso
la sottostante vasca. La seconda vasca,
realizzata nella parte alta del vallone, ha
dei muri di sponda di altezza ridotta
rispetto al canale di monte e di valle. In
tal modo le portate più elevate, che non
sono contenute nel canale centrale lungo 150
m, esondano in dodici sacche laterali
limitate da muri longitudinali e setti
trasversali in grado di contenere un volume
complessivo di circa 10.000 mc. Inoltre, si
stanno studiando gli effetti di una terza
vasca già progettata, anch’essa di un
volume di accumulo pari a 35.000 mc e dotata
di un dispositivo per la separazione delle
portate idriche separate da quella delle
eventuali portate di fango, mediante la
realizzazione di un dispositivo in scala
1/40 che è realizzato nel Comune di
Quindici. Per quanto riguarda invece la fase
di ricostruzione, è necessario rilevare che
ben 67 miliardi sono stati stanziati a
seguito di ordinanza nell’ambito del Dl
132/1999, ma che la legge giace inapplicata.
Infatti, lo stesso subcommissario
responsabile della messa in sicurezza e
della ricostruzione del territorio, dopo
l’evento Sarno, spiega che la prima citata
ordinanza avrebbe voluto dire abbandonare i
luoghi distrutti. Per evitare questo, è
stata creata la carta della pericolosità,
attraverso la quale ogni cittadino potrà
essere informato sulla possibilità di
ricostruzione del proprio edificio
danneggiato nello stesso posto in cui si
trovava prima degli eventi calamitosi, se
questo non sarà possibile si provvederà a
garantire un risarcimento. Il cittadino,
allora, sarà lasciato libero di decidere se
avere un rimborso pari alle spese di
ricostruzione o di riavere la propria casa
ricostruita. Si sarebbe già dovuto essere
in grado di ripartire con la ricostruzione,
salvo problemi di illegittimità che
potrebbero sorgere nell’applicazione del
decreto prima citato. Questi problemi
riguardano solo il Comune di Sarno, giacché,
per gli altri comuni commissariati (Bracigliano,
Siano e Quindici) non è ancora in programma
la realizzazione di una carta della
pericolosità, e sarà quindi necessario più
tempo per iniziare la ricostruzione.
|
Figura 1
|
|

|
Ritornando alla prima fase di messa in sicurezza, c’è da notare che
la maggior parte delle opere realizzate
consistono nel rifacimento, in cemento
armato, dei canaloni naturali interessati
dalle colate. La logica seguita per la
realizzazione di quest’intervento, quindi,
poco ha a che fare con quelli che sono i
problemi della tutela dell’ambiente e
della sua integrità, ma mira esclusivamente
alla riduzione del rischio.
Ma siamo sicuri che
questo sia il metodo migliore? La forte
cementificazione appena descritta sarà in
grado di garantire, da sola, la stabilità
richiesta?
Certo è che in nessuno di questi luoghi, si è pensato di provvedere
al recupero del patrimonio forestale che era
presente prima degli eventi calamitosi.
Molto banalmente, chiunque potrebbe pensare
che questo tipo di catastrofi avvengano
perché non ci sono più alberi in grado di
garantire la stabilità ai pendii. Questo
aspetto sembra non aver minimamente
interessato i vari organi tecnici e
istituzionali preposti alla difesa
dell’area in esame. A tal fine
l’ingegneria naturalistica propone metodi
alternativi alla risoluzione dei problemi in
questione. L’ingegneria naturalistica è
una tecnica che studia la possibilità di
uso di piante in unione con materiali non
viventi (pietrame, terra, legname) come pure
materiali da costruzione. L’efficacia di
questa tecnica è proporzionata alla capacità
di attenuare l’azione battente della
pioggia, alla capacità di trattenere acqua
e alla densità dell’apparato radicale
delle piante utilizzate. Bisogna, inoltre,
fare in modo che il manto vegetale
utilizzato sia in grado di svilupparsi nel
minore tempo possibile nel rispetto,
s’intende, delle specie arboree
preesistenti. Utilizzare, infatti, piante
completamente estranee al luogo prescelto,
oltre a comportare chiari impatti negativi
sull’ecosistema originario, potrebbe non
garantire l’attecchimento della specie
prescelta, con evidenti conseguenze sulla
stabilità desiderata. Le tipologie di
intervento possono essere classificate in
due gruppi: interventi di tipo radicante
intensivo e interventi di tipo radicante
estensivo. Il primo gruppo riguarda il
rivestimento arboreo e consiste
nell’utilizzare alberi che riescono a
radicare in maniera profonda nel terreno. Il
secondo gruppo riguarda per lo più le
piante erbacee, che espandono le loro radici
in maniera meno profonda rispetto alla
tipologia prima descritta, ma in ogni modo
efficace per la formazione di fitti cespi di
radici che ricoprono totalmente il volume di
suolo interessato dall’intervento. È
inutile rilevare che gli alberi garantiscono
un miglior aggrappamento al suolo, ma su
versanti fragili il peso proprio di un tale
tipo di intervento (radicante intensivo) può
essere gravemente pericoloso perché capace
di favorire il denudamento integrale in caso
di frane e slittamenti. I processi mediante
i quali le piante influenzano la stabilità
dei pendii possono essere raggruppati in
processi meccanici e idrologici. I primi
sono collegati alla capacità delle radici
di interagire fisicamente con lo strato di
suolo di cui fanno parte, i secondi sono
collegati ai rapporti che s’instaurano fra
ciclo idrologico e vegetazione. La massa
delle radici può raggiungere valori
compresi tra la metà e un terzo della massa
epigea dell’albero, dove per massa epigea
s’intende la parte della pianta che si
trova fuori del terreno. La possibilità di
formare radici estese, inoltre, è
influenzata anche dalle condizioni locali:
il salice, ad esempio, forma radici piatte
in un terreno fertile e radici laterali in
ambiente secco. La capacita delle radici di
bonificare terreni franosi è maggiore per
terreni che sono soggetti a scivolamenti
tipo earth flow e debris flow
(la classificazione cui si è accennato
divide le frane da scivolamento in due
categorie: la prima caratterizzata dalla
presenza di materiale sciolto, la seconda
caratterizzata dalla presenza di materiale
più compatto). In generale si può
affermare che la profondità della zona di
influenza varia dai 10 cm circa per le
piante erbacee ai 2-3 m per gli
arbusti.
|
Figura 2 -
Schema idraulico della vasca Petraro;
invaso fuori linea per la raccolta
dei materiali fangosi in eccesso
relativi al vallone San Francesco
(Quindici, Av) |
|
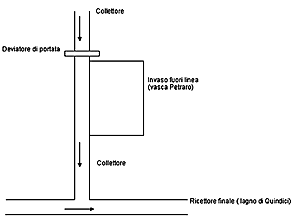
|
|
|
È fondamentale che le piante approfondiscano le loro radici in uno
strato più resistente di quello da
stabilizzare. Per avere questa condizione
è necessario che sia presente o un
substrato fratturato e, quindi,
raggiungibile, oppure sia presente uno
strato di transizione attraverso il quale
si verifichi un incremento della
resistenza dall’alto verso il basso. Uno
degli esempi più interessanti,
classificabili tra gli interventi di tipo
radicante estensivo, è quello fornito
dall’azienda della Lomellina Vetivaria
nella quale si studiano e si applicano gli
effetti stabilizzanti del vetiver nella
sistemazione dei pendii. Il vetiver è una
pianta perenne che può essere innestata
come pianta sterile, evitando così i
problemi di impatto ambientale cui prima
si è accennato. Una delle caratteristiche
peculiari di questa pianta è di essere
supportata da una grossa massa di radici
spugnose che crescono verticalmente in
maniera relativamente rapida, in questo
modo si può garantire un robusto
attecchimento al suolo senza copromettere
la vita delle piante preesistenti. Questo
tipo di intervento si distingue dagli
interventi strutturali classici
(calcestruzzo armato, massicciate,
terrapieni, eccetera) giacché il vetiver
non è una barriera strutturale morta, ma
una barriera vegetale naturale viva ed
autoadattante: mentre le sue radici
penetrano profondamente nel terreno, la
parte aerea della pianta cresce formando
una siepe fitta, alta fino a due metri che
trattiene la terra e, nel caso di
esondazioni, rallenta il flusso
dell’acqua, trattenendone nello stesso
tempo fango e detriti. Vengono così a
crearsi dei terrazzamenti a monte che
comportano, per il loro effetto
consolidante, una forte riduzione
dell’erosione superficiale dovuta alle
acque ruscellanti. Questa pianta, resiste
in terreni con ph variabile tra 4 e
12, e può sopportare intervalli di
temperatura compresi tra -35°C e +45°C.
A questo proposito ricordiamo che esistono
due specie di vetiver: il vetiver grass
e il cold vetiver, la prima
particolarmente indicata per le zone a
grossa escursione termica, la seconda ai
climi freddi.
|
Figura 3 -
Schema idraulico a doppio invaso
fuori linea, a monte della vasca
Petraro per la sistemazione
idraulica del vallone San
Francesco (Quindici, Av)
|
|
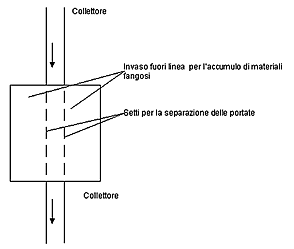
|
L’ingegneria naturalistica da sola, sicuramente, non riuscirebbe a
risolvere problemi così grandi come
quelli che si sono avuti nel sarnese, ma
dimenticarsene totalmente non è certo una
scelta corretta.
Come già precedentemente accennato, il lavoro si pone come obiettivo
finale quello di creare le basi per la
redazione di una proposta innovativa per
la gestione del rischio territoriale,
mirata, fra l’altro, ad un
coinvolgimento maggiore degli abitanti
delle aree a rischio. Per fare questo si
sono approfondite le metodologie
urbanistiche della pianificazione
partecipata. Pianificare in maniera
partecipata vuol dire, in generale,
coinvolgere le persone nelle scelte
relative alla gestione del territorio in
modo da cercare, quanto più possibile, di
rispondere ad esigenze concrete. Nelle
aree a rischio questo metodo di
pianificazione permette di creare un
interessante scambio d’opinioni e
d’informazioni con i residenti.
Purtroppo la pianificazione partecipata
nelle aree a rischio e, in particolare,
nelle aree a rischio idrogeologico, è una
disciplina che non trova larga
applicazione. Il motivo di questa mancanza
potrebbe risalire ad un’ignoranza
storica. Infatti, fin dai secoli scorsi
proprio nell’Italia meridionale e, più
in particolare, nella zona di Sarno e
comuni limitrofi (Nocera, S. Egidio del
monte Albino ecc.) erano in vigore leggi
che ponevano le basi per un approccio
partecipato alla gestione del rischio
territoriale. Uno dei primi decreti è
quello n. 168, anno 1806, in cui si ordina
l’osservanza delle leggi e degli
stabilimenti anteriori per la
conservazione delle strade e canali e si
stabilisce che le terre, piane e montuose,
prospicienti strade o canali, non possono
modificare il loro stato nel caso in cui
fosse stato prescritto che i terreni non
potevano essere coltivati.
Analogamente
boschi o fratte non si potevano abbattere
o diradarsi senza permesso regio, concesso
con le debite regole su supporto del
Ministro dell’interno. I possessori
delle terre vicine alle strade avevano
l’obbligo di tenere sempre puliti i
fossi per facilitare lo scolo delle acque.
Ma il riferimento originario per tutti i
decreti su esposti rimane “lo Editto per
la salvaguardia delle selve e dei
boschi” del 1749. Questo non solo
imponeva la tutela e la vigilanza sui
boschi e le foreste affinché non fossero
devastate e distrutte, ma proibiva anche
di tagliare gli alberi il cui frutto era
adatto all’ingrasso degli animali, come
querce, cerri, esiche, olmi, pini, faggi,
ecc. “I terreni dovranno restare adibiti
all’uso delle selve, che non potranno
mai essere tagliate per ridurre i terreni
a coltura”. I trasgressori sarebbero
stati sottoposti a severa pena.
Tornando alla redazione di una proposta innovativa si può osservare
che, lì dove l’urbanizzazione è già
presente, può essere creata una vera e
propria struttura di controllo e
monitoraggio costituita dagli stessi
abitanti del posto. Le persone diventano
così delle sentinelle sempre
presenti sul territorio che controllano
l’eventuale istaurarsi di fenomeni ad
alto rischio. Uno degli strumenti migliori
per l’acquisizione di questo tipo di
dati da parte delle strutture preposte
alla gestione del rischio è Internet. In
breve, le persone via e-mail, o mediante
la connessione ad un sito specifico,
potrebbero informare le autorità su
eventuali fenomeni d’allarme che
verrebbero a verificarsi sul territorio in
cui vivono. Tutto questo, inoltre,
andrebbe supportato dall’istituzione di
un programma di informazione e di
coinvolgimento sul territorio da
realizzarsi con delle scadenze precise e
prefissate. In ogni area interessata dal
rischio dovrebbero costituirsi, quindi,
delle strutture a carattere locale che
fissino degli incontri, ad esempio
settimanali, attraverso i quali i dati
siano resi pubblici allo scopo di un
aggiornamento periodico dello sviluppo dei
possibili eventi di allarme.
Parallelamente a quest’attività va
istituita una struttura (questa volta
costituita da tecnici e da esperti) che
analizzi in modo scientifico i problemi e
che contribuisca, per quanto possibile,
alla loro risoluzione. Indispensabile,
quindi, realizzare dei comitati
scientifici che lavorano esclusivamente su
zone limitate di territorio effettuando un
monitoraggio costante.
I passi fondamentali da seguire nella creazione di un modello
innovativo di gestione del rischio
territoriale sono quindi i seguenti:
1. individuazione e perimetrazione delle aree in cui il rischio è
evidente: per fare questo sono coinvolti
non solo comitati tecnici e scientifici
locali, ma particolare importanza assume
il coinvolgimento degli abitanti del
posto;
2. creazione di una struttura finalizzata alla gestione di dati
acquisiti: per fare questo bisogna partire
dalle autonomie locali già esistenti che
si occupano di tutela e gestione del
territorio, spingendole verso la creazione
di un vero e proprio centro di smistamento
dei dati che, oltre a contribuire alla
creazione delle aree di cui al punto
precedente, si occupi
dell’incentivazione sul territorio di
stimoli e sensibilizzazioni per una
migliore gestione del rischio
territoriale;
3. sovrapposizione delle scelte fatte con le esigenze sul territorio:
è importante controllare che le scelte
effettuate per la gestione del rischio
territoriale vadano a tenere conto di
tutte le esigenze sul territorio per far sì
che gli interventi non risultino
inadeguati e, quindi, poco efficaci.
|
Figura 8
|
|

|
* Mario Elia si è laureato in ingegneria civile nel
luglio 2001, presso l’Università di
Salerno, discutendo una tesi di Tecnica
Urbanistica su “Principi e pratiche per
un approccio innovativo alla gestione del
rischio territoriale”, relatore il Prof.
Ing. Roberto Gerundo, correlatore il Dott.
Ing. Isidoro Fasolino
|